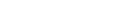Bellissima valle ai piedi delle Alpi lombarde, al confine italo-svizzero, sulla riva destra del fiume Adda, possiede 40 km di alti pendii che si estendono in terrazzamenti di vigne, formati da migliaia di muretti di pietre a secco.
Le catene delle Prealpi Orobiche e delle Alpi Retiche difendono le vigne sia dai venti freddi del nord che da quelli umidi del sud come lo Scirocco, l’esposizione ai forti raggi del sole di montagna è ottimale e le forti escursioni termiche tra giorno e notte favoriscono l’espressione del vitigno principe del luogo, il Nebbiolo, qui chiamato Chiavennasca.
Pare che siano stati i Liguri e i Piemontesi a trasportare questo vitigno in Valtellina, zona rivelatasi poi particolarmente vocata per la sua coltivazione, nel versante sud dove risulta molto ben esposta, molto meno a nord, verso la Svizzera.
La presenza del sole e il perfetto drenaggio del terreno, pendente e ben canalizzato, sono gli elementi favorevoli per la coltivazione vitivinicola.
Le vigne situate tra i 300 e i 900 m. s.l.m, sono disposte in ripidi filari a ritocchino con sistema tradizionale ad archetto valtellinese, un tipo di Guyot modificato in cui il capo a frutto, invece di essere disteso sul filo portante, viene curvato verso il basso.
Le gemme sono circa 18-24 per pianta e la densità è di circa 3000/3700 ceppi/ettaro. L’età media delle viti supera i 50 anni e la produzione è di 80/100 quintali per ettaro.
La Chiavennasca, che è un clone del Nebbiolo, cresce ad altitudine rilevante ed è un monovitigno in quasi tutta la valle; è considerata localmente un vitigno autoctono per la sua antica coltivazione e per le sue caratteristiche pedoclimatiche. Altri vitigni sono: la Rossola Nera, la Pignola Valtellinese, il Fortana, che concorrono all’uvaggio per circa il 10% della produzione.
Fin da tempi antichi, la vite è stata la principale fonte di sostentamento delle popolazioni locali, sia come alimento sia come diffusa merce di scambio con altri generi di prima necessità.
Il terroir della Valtellina è vario e comprende sia depositi ghiaiosi-ciottolosi che substrati rocciosi. I terrazzamenti sono essenzialmente terra di riporto, portata a spalla fin dai tempi dei Romani e bloccata con muretti, situazione che, oggi, dà luogo alla cosiddetta “vendemmia eroica”.
Nell’Ottocento la Valtellina fu contesa tra gli Svizzeri e gli Italiani ed ancora oggi ci sono quattro paesi svizzeri che producono docg italiano.
Nel 1946 fu stipulato un accordo secondo il quale la Svizzera aveva diritto ad acquistare il vino della Valtellina e tale contratto ebbe vigore fino al 1976 , offrendo ai produttori la possibilità di ottimi guadagni. Nel 1976 venne inoltre fondato il Consorzio Tutela Vini della Valtellina con Statuto e Regolamento per la produzione dei vini a Denominazione di Origine e ad Indicazione Geografica Tipica.
Nel 1978 la Svizzera ruppe il patto unilaterale e fu allora che l’Azienda Nino Negri, in piena crisi di produzione della valle, decise di puntare su un concetto moderno di vinificazione, con controllo di temperatura di fermentazione e con affinamento in barrique e botti di legno.
Le denominazioni, oggi, sono le seguenti:
1) Docg Valtellina Superiore con le 5 sottozone
Docg Valtellina Superiore Maroggia
Docg Valtellina Superiore Sassella
Docg Valtellina Superiore Grumello
Docg. Valtellina Superiore Inferno
Docg Valtellina Superiore Valgella
2) Doc Rosso di Valtellina
3) Docg Sforzato di Valtellina.
Per tutti le rese sono basse. Le uve di Valtellina non danno né intensità né calore ma le acquistano se sono appassite e garantiscono un vino potente e, al tempo stesso, etereo ed elegante; l’uso della barrique, poi, ha accentuato potenza e colore nella Chiavennasca.






 Leave a Reply
Leave a Reply